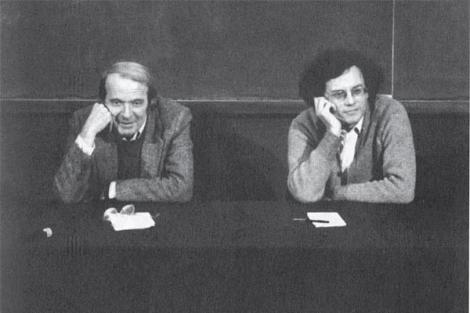Posted: Febbraio 28th, 2012 | Author: agaragar | Filed under: au-delà, post-filosofia | 7 Comments »
intervista a Giorgio Agamben
a cura di Franco Marcoaldi (la Repubblica, 8 febbraio 2011)
Giorgio Agamben. «Nella nostra cultura esistono due modelli di esperienza della parola. Il primo modello è di tipo assertivo: due più due fa quattro, Cristo è risorto il terzo giorno, i corpi cadono secondo la legge di gravità. Questo genere di proposizioni sono caratterizzate dal fatto che rimandano sempre a un valore di verità oggettivo, alla coppia vero-falso. E sono sottoponibili a verifica grazie a un’adeguazione tra parole e fatti, mentre il soggetto che le pronuncia è indifferente all’esito.
Esiste però un altro, immenso ambito di parola del quale sembriamo esserci dimenticati, che rimanda, per usare l’intuizione di Foucault, all’idea di “veridizione”. Lì valgono altri criteri, che non rispondono alla separazione secca tra il vero e il falso. Lì il soggetto che pronuncia una data parola si mette in gioco in ciò che dice. Meglio ancora, il valore di verità è inseparabile dal suo personale coinvolgimento».
 |
| Giustiniano, mosaico nella chiesa di San VItale a Ravenna |
Il senso profondo del credere andrebbe dunque ricercato proprio qui?
«Certamente. Anche se, nel corso del tempo, il trionfo del primo modello, quello assertivo, ha di fatto cancellato il secondo. Mi fanno sorridere i confronti, oggi molto in voga, tra credenti e non credenti: veri e propri dialoghi tra sordi, visto che preti e scienziati condividono da versanti opposti lo stesso modello di verità. Poco importa che si discuta di leggi fisiche o teologiche, che naturalmente si elidono tra loro. Si tratta in ogni caso di proposizioni assertive. La confusione tra ciò che possiamo credere, sperare e amare e ciò che siamo tenuti a considerare vero, oggi ci paralizza».
Quando sarebbe stato cancellato il secondo tipo di esperienza con la parola?
«Nella tradizione dell’Occidente, è stato Aristotele ad affermare che la filosofia deve occuparsi soltanto delle proposizioni che possono risultare vere o false. Eppure esisteva ed esiste un’altra esperienza della parola: quella della promessa, della preghiera, del comando, dell’invocazione, che è stata esclusa dalla riflessione filosofica. Naturalmente, ciò non significa che essa non abbia continuato ad agire: il diritto e la religione si fondano su di essa».
Un esempio?
«Il più importante di tutti: San Paolo, che definendo la parola della fede, non fa riferimento a criteri di verità, ma parla di vicinanza tra cuore e labbra. È significativo che, tranne una volta, egli usi sempre l’espressione, da lui inventata, “credere in Gesù Cristo” e non, come sarebbe stato normale in greco, credere che Gesù è il figlio unigenito di Dio, eccetera. -La differenza è sostanziale. La Chiesa, attraverso i suoi concili, ha cercato di fissare la fede in dogma, in un’esperienza di tipo assertivo. E così si è smarrito un tratto fondamentale della natura umana, che esige una fede estranea a una logica puramente fattuale. La vera fede non aderisce a un principio prestabilito ed è singolare che proprio la Chiesa, che doveva preservare questa idea, se ne sia dimenticata. Da qui la formula “Credo perché è assurdo”».
Quali sono i riflessi negativi di tale logica assertiva sulla nostra vita sociale?
«Infiniti. Pensi all’etica: si afferma che per agire bene bisogna disporre di un sistema di credenze prefissato. Dunque, agirebbe bene soltanto colui che ha una serie di principi a cui deve conformarsi. È il modello kantiano, ancora imperante, che definisce l’etica come dovere di obbedire a una legge. Quando lavoravo sull’idea di “testimonianza”, mi colpì la storia di una ragazza che, sottoposta a tortura dalla Gestapo, aveva rifiutato di rivelare i nomi dei suoi compagni. A chi più tardi le chiese in nome di quali principi era riuscita a farlo, rispose soltanto “l’ho fatto perché così mi piaceva”. L’etica non significa obbedire a un dovere, significa mettersi in gioco: in ciò che si pensa, si dice e si crede».
Anche perché, travolta la credenza nell’infallibilità di quella certa legge, rimane un campo di rovine.
«Prima o poi accade a tutte le credenze di tipo oggettivo. E difatti: le credenze politiche si sono letteralmente sbriciolate, quelle teologico-religiose si fossilizzano in dogmi contrapposti. Per quanto riguarda quelle scientifiche, esse risultano completamente irrelate rispetto alla vita etica dei singoli individui».
In Credere e non credere Nicola Chiaromonte formula una domanda secca: si può credere da soli?
«È una domanda pertinente. Che io riformulerei in questo modo: com’è possibile condividere una verità o una fede che non siano di tipo assertivo? Io penso che questo accada nei territori dell’esistenza in cui ci si mette in gioco personalmente. Se la veridizione è lasciata ai margini e il solo modello della verità e della fede diventano la scienza e il dogma, la vita diventa invivibile. Di qui l’indifferenza e lo scetticismo generalizzato, oltre che la tetraggine sociale dilagante. Soltanto procedendo a ritroso, ricercando quella diversa esperienza di parola, si può tornare al rapporto originario con la verità, irriducibile a qualunque sua istituzionalizzazione.
Le faccio un esempio: la scienza guarda al passaggio dal primate all’uomo parlante unicamente in termini cognitivi, come se fosse soltanto una questione di intelligenza e di volume cerebrale. Ma non c’è solo questo aspetto. La trasformazione deve essere stata altrettanto gigantesca dal punto di vista etico, politico, sensibile. L’uomo non è solo homo sapiens. È un animale che, a differenza degli altri viventi, i quali non sembrano dare importanza al loro linguaggio, ha deciso di correre fino in fondo l’azzardo della parola. E da qui è nata la conoscenza, ma anche la promessa, la fede, l’amore, che esorbitano la dimensione puramente cognitiva».
È una strada ancora aperta?
«L’uomo non ha ancora finito di diventare umano, l’antropogenesi è sempre in corso. Menandro ha scritto: “com’è grazioso – cioè capace di gratuità – l’uomo quando è veramente umano”. È questa gratuità che dobbiamo riscoprire. Tanto più che i modelli di credenza che ci vengono proposti non ci persuadono più. Sono, come diceva Chiaromonte, mantenuti a forza, in malafede».
Proviamo dunque a perimetrare il novero di queste credenze più genuine, anche se sotterranee, sommerse.
«Prendiamo la politica: perché non interroga finalmente la vita delle persone? Non la vita biologica, la nuda vita, che oggi è continuamente in questione nei dibattiti spesso vani sulla bioetica, ma le diverse forme di vita, il modo in cui ciascuno si lega a un uso, a un gesto, a una pratica. Ancora: perché l’arte, la poesia, la letteratura, sono museificate e relegate in un mondo a parte, come se fossero politicamente e esistenzialmente irrilevanti?».
Anche lo scrittore russo Alexandr Herzen lamentava a suo modo la cancellazione dell’esperienza vitale soggettiva. Affermando che crediamo in tutto, tranne che in noi stessi.
«Viviamo in società abitate da un Io ipertrofico, gigantesco, nel quale però nessuno, preso singolarmente, può riconoscersi. Bisognerebbe tornare all’ultimo Foucault, quando rifletteva sulla “cura di sé”, sulla “pratica di sé”. Oggi è rarissimo incontrare persone che sperimentino quella che Benjamin chiamava la droga che prendiamo in solitudine: l’incontro con sé stessi, con le proprie speranze, i propri ricordi e le proprie dimenticanze. In quei momenti si assiste a una sorta di congedo dall’Io, si accede a una forma di esperienza che è l’esatto contrario del solipsismo. Sì, penso che si potrebbe partire proprio da qui per ripensare un’idea diversa del credere: forme di vita, pratica di sé, intimità. Queste sono le parole chiave di una nuova politica».
Posted: Febbraio 24th, 2012 | Author: agaragar | Filed under: epistemes & società, Marx oltre Marx, post-filosofia | Commenti disabilitati su Il sacro dilemma dell’inoperoso
di Toni Negri
La pubblicazione di «Opus dei» del filosofo italiano per Bollati Boringhieri
è la conclusione di un percorso teorico inziato con «Homo Sacer». La posta
in gioco è sempre stata teoretica, cioè l’essere, e ha comportato un corpo a
corpo con «l’ideologia europea». Ma ad ogni tappa sono stati affrontati temi
centrali in una auspicabile politica della trasformazione. Un nichilismo
radicalizzato dove non c’è spazio per la storia.
Con questo Opus dei (Bollati Boringhieri, pp. 155, euro 15) sembra
concludersi il cammino che il filosofo italiano Giorgio Agamben ha
intrapreso con Homo Sacer. Un bel tratto di strada, dai primi anni Novanta
del Novecento, un ventennio. Un’archeologia dell’ontologia condotta (con un
rigore che neppure il gioco bizzarro e fuorviante dei numeretti messi a
fingere un ordine per diversi stadi della ricerca è riuscito a rendere
opaco) – fino ad una riapertura del problema del Sein (l’essere). Uno scavo
quale neppure a Martin Heidegger (a dire dell’autore che qui si rivendica
giovane allievo del filosofo tedesco) era riuscito – perché qui l’ontologia
è liberata da ogni vestigia di «operatività», da ogni illusione che essa
possa legarsi alla volontà ed al comando. Che cosa ne resta? «Il problema
della filosofia che viene è quello di pensare un’ontologia al di là
dell’operatività e del comando, e un’etica e una politica del tutto liberate
dai concetti di dovere e volontà».
La dimostrazione che l’ontologia criticata da Heidegger sia ancora, al
fondo, una teoria dell’operatività e della volontà, è idea indubbiamente
vera. Già Schürmann l’aveva sviluppata quando aveva criticato il Sein come
l’idea stessa di «arché», e dunque come indistinzione di inizio e di
comando. Seguire lo sviluppo e l’organizzazione successiva di
quest’ontologia dell’operatività, che dai neoplatonici ai padri della
Chiesa, dai filosofi latini a Kant, da Tommaso a Heidegger pone un’idea
dell’essere completamente assimilata a quella della volontà/comando, è
compito da Agamben qui assolto con grande maestria.
In debito con la religione Aristotele, prima di tutti. Nella sua teoria
della virtù come abito, egli avrebbe potuto strappare l’essere ad ogni
pulsione aporetica verso la virtù e così liberarsi di ogni operatività
valorifica: non ce la fa, pur essendo colui che, alle origini della
metafisica, aveva concepito la virtù come rapporto con la privazione e come
determinazione ontologica inoperosa. Ma di qui in avanti – secondo Agamben –
le cosa vanno di male in peggio. Nel cristianesimo (ancora una volta
l’immersione nel rapporto fra neoplatonismo e patristica sollecita Agamben
nel suo procedere) azione e volontà cominciano a farla da padroni. Lasciamo
ai medievisti il giudizio sulla correttezza dell’analisi agambeniana: a noi
basta seguirne il filo che mostra una indubbia coerenza. Ora, l’aporia
aristotelica che si definiva nell’alternativa di collegare (o non collegare)
l’abito e la virtù, l’essere ed il dovere, la passività e l’attività, nella
Scolastica viene meno. L’abito critico è piuttosto ordinato costitutivamente
all’azione e la virtù non consiste più nell’essere ma nell’operare – ed è
solo attraverso l’azione che l’uomo si assimila a Dio. Così in Tommaso: «È
questa ordinazione costitutiva dell’abito all’azione che la teoria delle
virtù sviluppa e spinge all’estremo». D’ora in poi la storia della
metafisica, scarnificata dall’archeologia critica, mostra una bella
continuità e rivela una sorta di ansia perversa (secondo Agamben) di
svolgere ed approfondire quel principio operativo dell’etica e quel concetto
di virtù come obbligo e dovere che la teologia medioevale le aveva concesso
in eredità. Il «debito infinito» in cui consiste, secondo i filosofi della
Seconda Scolastica, il dovere religioso, viene così definitivamente
impiantandosi nelle metafisiche della modernità. Con Kant fa la prima
comparsa l’idea di un compito e di un dovere infiniti, irraggiungibili ma
non per ciò meno doverosi. In un passo esemplare Agamben riassume: «Qui si
vede con chiarezza che l’idea di un “dover-essere” non è soltanto etica né
soltanto ontologica: essa lega, piuttosto, aporeticamente essere e prassi
nella struttura musicale di una fuga in cui l’agire eccede l’essere non
soltanto perché gli detta sempre nuovi precetti, ma anche ed innanzitutto
perché l’essere stesso non ha altro contenuto che un puro debito». Nelle
pagine successive Agamben insiste polemicamente sull’interiorizzarsi
dell’idea della legge morale, sul suo approfondirsi della forma
dell’autocostrizione e persino del piacere masochista nella legge. «La
sostituzione del “nome glorioso di ontologia” con quello di “filosofia
trascendentale” significa, appunto, che un’ontologia del dover-essere ha
preso ormai il posto dell’ontologia dell’essere».
Una trattazione ed una conclusione del tutto heideggeriane, si direbbe. E
però, lo si avverte da subito, questo riferimento delude Agamben. «Anche
Heidegger sviluppa un’ontologia che è più solidale di quanto si creda con il
paradigma dell’operatività che intende criticare». Restiamo stupiti da
questa affermazione. Non era dunque andato abbastanza avanti Heidegger nella
sua distruzione dell’ontologia della modernità? Non aveva già abbastanza
scarnificato il Sein – l’essere – di quanto di umano gli si poteva
attribuire? No – insiste Agamben – c’è un punto nel
quale Heidegger cede alla tentazione di un’ontologia operativa: sono la
teoria della tecnica, la critica del Gesell che scoprono questa
irresolutezza. «Non si comprende l’essenza metafisica della tecnica, se la
si intende solo nella forma della produzione. Essa è, altrettanto e
innanzitutto governo e oikonomia, che, nel loro esito estremo, possono anche
mettere provvisoriamente fra parentesi la produzione causale in nome di
forme più raffinate e diffuse di gestione degli uomini e delle cose».
Auschwitz insegna! Già nel Regno e la gloria, con un po’ di attenzione, si
sarebbe potuta leggere questa conclusione.
Il distacco da Heidegger Qui mi nasce un sospetto. E cioè che questo libro,
Opus Dei, benché riassuma e sviluppi, come già detto, le analisi di Il Regno
e la gloria, in realtà non sia solo il completamento di quel filone
archeologico di pensiero e di lavoro agambeniani. Questo libro segna
piuttosto il definitivo distacco di Agamben da Heidegger: la scelta
ontologica sovrasta la qualità archeologica dell’analisi e lo scontro si
innalza a livello fondamentale. Heidegger è qui accusato d’esser
riuscito solo ad una provvisoria soluzione delle aporie dell’essere e del
dover-essere (ovvero dell’operatività): indeterminazione più che
separazione, più che scelta di un altro terreno ontologico. Debbo ammettere
di aver provato una certa soddisfazione rilevandolo. Ma essa fu breve. Qual
è infatti il Sein ulteriormente imperscrutabile che Agamben ora, pur contro
Heidegger,ci propone? Già una volta, nel 1990, prima di avventurarsi nella
lunga vicenda dell’Homo Sacer, in La Comunità che viene, Agamben si era
allontanato da Heidegger: aveva allora ceduto ad una sollecitazione
benjaminiana, quasi marxista, nel promuovere una sfida sul senso umanistico
dell’essere. Ora, non è certo in questo senso che Agamben procede. Si
muove, al contrario, contro ogni umanesimo, contro ogni possibilità di
azione, contro ogni speranza di rivoluzione.
Ma come ci è arrivato, Agamben, a questo nihilismo radicalizzato, agitandosi
nel quale si compiace di aver superato (o portato a termine) il progetto di
Heidegger? Ci arriva attraverso un lungo percorso che si articola su due
direzioni: una di critica propriamente politico-giuridica, l’altra
archeologica (uno scavo teologico-politico). Carl Schmitt è al centro di
questo cammino: ne guida le due direzioni, quella che porta alla
qualificazione del potere come eccezione, e dunque come forza e destino,
strumentazione assoluta e senza qualità di ogni tecnica, e sadismo della
finalità; d’altro lato quella che porta alla qualificazione della potenza
come illusione teologica, ovvero impotenza, e cioè affidamento impossibile
all’effettualità, quindi: incitamento all’inoperatività, quindi denuncia
della frustrazione necessaria del volere, del masochismo del dovere. Le due
cose vanno assieme. È quasi impossibile, recuperata l’attualità
dei concetti schmittiani dello «Stato di eccezione» e del
«teologico-politico» comprendere se essi rappresentino il più grande
pericolo o invece se si tratti semplicemente di una apertura alla loro
verità. La metafisica e la diagnostica politica si arrendono
all’indistinzione. Ma ciò sarebbe
forse irrilevante se in questa indistinzione non fosse annegata ogni
possibile resistenza. Ritorniamo alle due linee identificate: tutto il
percorso che segue Homo Sacer si svolge su questo doppio binario. La seconda
linea è sommarizzata da Il Regno e la gloria.
La virtù efficace Insistiamo: anche questa seconda linea è mossa dalla
Teologia politica di Carl Schmitt e dal confronto con l’ontologia di
Heidegger. Diciamo questo per evitare che si confonda l’archeologia
di Agamben con quella di Foucault. In Agamben manca la storia, quella storia
che in Foucault non è solo archeologia della modernità ma genealogia attiva
del presente, del suo darsi come del suo disfarsi, del suo essere come del
suo divenire. La storia, per Agamben, non esiste. Meglio, è al massimo
storia del diritto, che è appunto il solo luogo dove il filosofo può farsi
grammatico ed analista delle grammatiche del comando. Ma certamente anche il
luogo dove biopolitica e genealogia possono presentarsi solo in maniera
lineare – come destino, appunto.
Perché qui neppure l’ombra della soggettività, della produzione, appare – ed
anzi sembra che anche quest’ultima sia totalmente sommessa al blocco del
fare, della tecnica, dell’operare e, soprattutto, della resistenza.
Non stupiscono allora, in Opus Dei, le esemplificazioni giuridiche che
Agamben presenta a definitiva prova delle sue tesi. L’assolutizzazione del
dovere nel diritto sarebbe stata introdotta da Pufendorf più che da Hobbes
(e questo processo si conclude con Jean Domat). Può darsi.
Una lontana storia seicentesca, dunque, che marcia in contemporanea con la
nascita e lo sviluppo della Seconda Scolastica (quanto le deve lo stesso
Heidegger!) e della definitiva stabilizzazione di una metafisica
dell’operosità, della virtù efficace. Ma soprattutto importante,
perché è Kant che riprende questo motivo e, dopo Kant, Kelsen lo assolutizza
nella figura fondamentale del dovere giuridico, del Sollen. Si ricordi: non
è tanto la conclusione kelseniana che pur afferma la relazione fra diritto e
comando come doverosa, ad essere qui importante; l’importanza sta nel fatto
che essa riprende – mille miglia lontano dalla sua prima affermazione,
eppure vivente in tutta l’«ideologia europea» – quel nesso interno alla
liturgia che va dall’operatività economica all’essere divino, scendendo
omogeneamente attraverso le deduzioni giuridiche, fino alla necessità
fondante del Sollen: tutto ciò non rappresenta altro che il comando
imperscrutabile della divinità. Così, di Kelsen, si è fatto l’uguale di
Schmitt e le due linee aperte da Homo Sacer, si ricompongono: da un lato la
critica dell’eccezione e dall’altro la critica del Sollen, filtrata nella
oekonomia cristiana, in definitiva si unificano. Ma se questa riduzione può
essere – a grandissime linee e su un terreno che ormai non è più né
giuridico né politico – accettata; se è vero che la pratica di governo
fondata sul diritto di eccezione e sulla pretesa dell’efficacia economica,
hanno sostituito ogni forma costituzionale di governo; se, come
ricordava Benjamin tanto tempo fa, «ciò che è ormai effettivo è lo stato di
eccezione nel quale viviamo e che non sapremmo più distinguere dalla
regola»: bene, ciò detto, che cosa secondo Agamben può liberarci?
Giungiamo così al termine di un cammino complesso. Occorre liberarci dal
concetto e dalla potenza di volontà: così Agamben comincia a rispondere alla
questione. Dobbiamo liberarci dalla volontà che si vuole istituzione, che si
vuole efficacia ed attualità. Le ragioni le conosciamo. Nella filosofia
greca dell’età classica il concetto di volontà non ha significato
ontologico; questa deturpazione ontologica viene introdotta dal
cristianesimo, forzando elementi embrionalmente presenti in Aristotele; così
il dovere è introdotto nell’etica per dare fondamento al comando; così
l’idea di una volontà è elaborata per spiegare il passaggio dalla potenza
all’atto. In tal modo tutta la filosofia occidentale è posta dentro un
terreno di insolubili aporie che trionfa nella modernità piena, con il
ridefinirsi del mondo come prodotto di tecnologia e di industria (che cosa è
più evidente del realizzarsi, del divenire efficace del potere nella realtà,
nell’attualità – che cosa più di questo orizzonte?). Di nuovo si impone la
questione: come uscirne? Come riconquistare un essere senza effettualità?
Che bell’enigma ci ha regalato Agamben! Ci sarebbe forse una via che Agamben
a questo punto potrebbe ancora percorrere.
È quella dello spinozismo, cioè una via nella quale la potenza si organizza
immediatamente come dispositivo di azione, dove violenza e piacere si
determinano nelle istituzioni della moltitudine e la capacità costituente
diviene sforzo di costruire, nella storia, libertà, giustizia e
comune. Agamben percepisce questa via d’uscita, perfettamente atea. La
coglie infatti nell’insultante rifiuto dell’ateismo di Spinoza che, in un
momento critico della modernità, Pufendorf e Leibniz dichiarano. Ma l’essere
che Agamben ci presenta è, per ora, talmente nero e piatto, l’immanenza così
indistinta, l’ateismo così poco materialista, il nihilismo talmente triste
che Spinoza davvero non può stare al gioco – pur considerando, egli,
superstizione ogni ideologia dello stato che non fosse prodotto della
moltitudine e, fondamento intransitivo di libertà, il corpo (i corpi della
moltitudine). Né Spinoza, d’altra parte, sta ad attendere che le
forme di vita dell’Occidente siano giunte alla loro consumazione storica
(rifiutando nel frattempo di agire perché la volontà non morderebbe
l’effettualità). Sa invece dare risposta alla domanda sull’agire, sulla
speranza, sul futuro. Il positivo che avanza Che cosa sono i Lumi? È questa
la domanda che attraversa, con la filosofia di Spinoza, quelle di
Machiavelli e di Marx – e che, nell’attualità, è stata ripresa da Foucault.
Contro il nazismo ontologico di Heidegger. In fondo, l’unico luogo del lungo
tragitto percorso da Agamben, nel quale la soglia ontologica di potenza
potrebbe essere raggiunta, è quando, spostando l’accento dalle forme
linguistiche dell’essere storico, la forma di vita si stacca non dal diritto
in astratto ma da quel diritto storicamente dato (cioè dal diritto di
proprietà), non dal comando in generale ma da quel comando che è della
produzione capitalistica e del suo Stato. Lavorare alla dissoluzione del
diritto di proprietà e della legge del capitalismo è l’unico nihilismo
operativo che gli uomini virtuosi proclamano e agiscono. Ma anche questa
ipotesi Agamben scarta, recentemente, in Altissima povertà.
Come finirà questa storia? C’è una questione che, a fronte di un discorso
come quello di Agamben, nuovamente si apre: potrà forse la forma – ovvero
l’azione o l’istituzione – salvarsi dalla distruzione di ogni contenuto
doveroso? Chi, a questo proposito, insiste su toni e negazioni anarchiche è
tanto irritante quanto chi pensa che la continuità dell’istituzione o
l’annullamento di ogni azione negativa rappresentino la condizione di un
radicale passaggio in avanti. Probabile è invece, contro questi estremismi,
che come in altre epoche rivoluzionarie anarchismo e comunismo, in forme
nuove, sempre di più, nelle lotte che attraversano il nostro secolo, stiano
riavvicinandosi. In ogni caso, la sola cosa certa è, spinozianamente, che
«l’uomo guidato da ragione è più libero nello Stato, dove vive secondo un
decreto comune, che nella solitudine dove obbedisce soltanto a se stesso».
il manifesto
Posted: Febbraio 13th, 2012 | Author: agaragar | Filed under: bio, comune, Marx oltre Marx, post-filosofia | Commenti disabilitati su Il “nudo” e il “sacro”
La biopolitica di Giorgio Agamben
di Fabio Milazzo
“La storia della ratio governamentale,
la storia della ragione governamentale
e la storia delle contro condotte che le si sono opposte non possono essere dissociate l’una dall’ altra.”
Michel Foucault, Sicurezza, territorio e popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), p.365).

Nel 1979 Michel Foucault rese celebre il concetto di “biopolitica” dedicandogli un intero corso al Collège de France[1].
Durante il ciclo di lezioni Foucault cercò di dimostrare la correlazione tra il liberalismo, l’economia e il governo. L’economia, con il liberalismo, diventa il paradigma orientante le pratiche di governo.
“ Mi sembra che l’analisi della biopolitica non si possa fare senza aver compreso il regime generale di questa ragione governamentale di cui vi sto parlando, regime generale che si può chiamare questione di verità, in primo luogo della verità all’interno della ragione governamentale, e di conseguenza se non si comprende bene di che cosa si tratta in questo regime che è il liberalismo, (…) e una volta che avremo saputo che cos’è questo regime governamentale chiamato liberalismo potremo sapere cos’è la biopolitica”[2].
[…]
Posted: Febbraio 5th, 2012 | Author: agaragar | Filed under: epistemes & società, post-filosofia | Commenti disabilitati su aut aut

Inseriamo qui l’introduzione di Pier Aldo Rovatti al volume-antologia “Il coraggio della verità”, in cui ripercorre i sessant’anni della rivista: dalla fondazione (1951), a opera di Enzo Paci, si passa agli anni della fenomenologia (1960-69), al decennio dei bisogni (1970-79), all’intersezione con il pensiero debole (1980-89), ai nuovi autori ospitati nella rivista negli anni novanta (Foucault, Derrida…), fino ad arrivare alla “filosofia messa in gioco” (2000-2010).
[…]
Posted: Gennaio 23rd, 2012 | Author: agaragar | Filed under: epistemes & società, post-filosofia | 6 Comments »
Pierre Bourdieu con Sergio Benvenuto

Professor Bourdieu, nell’ambito del suo pensiero, lei ha elaborato il concetto di “violenza simbolica”. Che cosa intende con questa nozione?
La nozione di violenza simbolica mi è parsa necessaria per designare una forma di violenza che possiamo chiamare “dolce” e quasi invisibile, una violenza che svolge un ruolo importante in molte situazioni e relazioni umane. Per esempio, nelle rappresentazioni ordinarie, la relazione pedagogica è vista come un’azione di elevazione dove il mittente si mette, in qualche modo, alla portata del ricevente per portarlo a elevarsi fino al sapere, di cui il mittente è il portatore. Una visione non falsa, ma che maschera l’aspetto di violenza.
La relazione pedagogica, per quanto possa essere attenta alle attese del ricevente, implica un’imposizione arbitraria di un arbitrio culturale. Per fare un esempio, basta paragonare – come si sta iniziando a fare – gli insegnamenti della filosofia negli Stati Uniti, in Italia, in Germania, in Francia, ecc.: si vede, allora, che il Pantheon dei filosofi che ognuno di questi tipi nazionali di insegnamento impone ai discenti è estremamente diverso e una parte dei malintesi nella comunicazione tra i filosofi dei diversi paesi consistono nel fatto che essi sono stati esposti, all’epoca della loro prima iniziazione, a una certa arbitrarietà culturale. E a questo proposito che ho elaborato la nozione di “violenza simbolica”.
[…]
Posted: Dicembre 21st, 2011 | Author: agaragar | Filed under: epistemes & società, post-filosofia | 7 Comments »
di Francesca Fistetti

L’estate 2011 ha stupito noi lettori distratti da continue iniezioni televisive di iperrealtà con l’ennesima versione, forse anch’essa postmoderna, di una delle più dibattute polemiche filosofiche dell’ultimo decennio, quella tra ‘(neo-)realismo’ e ‘postmoderno’. Procediamo però con cautela, tentando di chiarire al meglio i termini della complessa questione.
Tutto ha inizio dal provocatorio manifesto di un presunto ritorno alla realtà, lanciato dalle colonne de “La Repubblica” da Maurizio Ferraris, noto filosofo formatosi alla scuola del ‘pensiero debole’ di Gianni Vattimo, oggi, vicino al trascendentalismo scientista di derivazione searliana. Il battesimo di questo esorcismo collettivo, che dovrebbe ricondurre finalmente quel che resta di un pensiero razionale e critico a riacciuffare le redini della Storia, riabilitando tre parole-chiave “Ontologia, Critica e Illuminismo”, dopo le superbe rodomontate postmoderne che hanno invece generato solo scioperataggine speculativa, sarà officiato in un importante convegno, a Bonn, nella prossima primavera, a cui parteciperanno nomi illustri del calibro di Umberto Eco e John Searle. Inoltre, il certificato di morte del postmoderno è ormai redatto e validato da una mostra londinese – ci informa Edward Docx, sempre dalle pagine culturali de “La Repubblica”[1] – al Victoria and Albert Museum, dal titolo emblematico, Postmoderno – Stile e sovversione 1970-1990.
[…]
Posted: Dicembre 21st, 2011 | Author: agaragar | Filed under: epistemes & società, post-filosofia | 8 Comments »
Schiudere spazi di libertà

Pubblichiamo qui la versione integrale della conversazione con Ida Dominijanni a cura di Enrico Donaggio e Daniela Steila
Anche a te chiediamo, come ai nostri precedenti interlocutori, se, a tuo avviso, in una situazione di grande emergenza civile come quella italiana, esiste un compito dell’intellettuale.
Il compito dell’intellettuale è sempre lo stesso: interpretare il presente, demistificare il potere, aprire spazi di libertà praticando, e non solo predicando, libertà. Michel Foucault ne ha dato una raffigurazione perfetta nei suoi commenti al testo kantiano Che cos’è l’Illuminismo? Naturalmente è lo stesso Foucault ad averci messo in guardia una volta per tutte da una certa concezione idealistica dell’intellettuale che lo vorrebbe estraneo al potere, ricordandoci che se il potere è sempre armato di sapere, il sapere a sua volta ha sempre a che fare con il potere: perché lo esercita e perché non c’è intellettuale, fosse pure il più critico, che non sia situato all’interno dello stesso regime di verità e dello stesso ordine del discorso della sua epoca che il potere garantisce e presiede. Mi sembra un punto rilevante per la situazione italiana di oggi.
[…]
Posted: Dicembre 21st, 2011 | Author: agaragar | Filed under: bio, Marx oltre Marx, post-filosofia | Commenti disabilitati su rizoma
di Edoardo Acotto
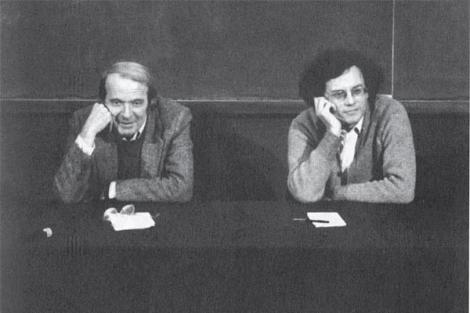
Presentato per la prima volta in un testo omonimo pubblicato dalle Éditions de Minuit nel 1976 e poi ripubblicato come primo capitolo (Introduzione) di Millepiani quello di rizoma è un concetto cardinale della coppia filosofica formata dai francesi Gilles Deleuze (filosofo) e da Félix Guattari (antipsichiatra).
“Il rizoma (da rizo-, radice, con il suffisso -oma, rigonfiamento) è una modificazione del fusto con principale funzione di riserva. È ingrossato, sotterraneo con decorso generalmente orizzontale” (da Wikipedia). Tuttavia nel repertorio concettuale di Deleuze & Guattari il rizoma indica tutt’altro che radicamento, verticalità e gerarchia (si pensi alla metaforica heideggeriana legata al Grund): il rizoma cresce infatti orizzontalmente e ha struttura diffusiva, reticolare, anziché arborescente. Il rizoma è un anti-albero, un’anti-radice, un’anti-struttura.
[…]
Posted: Novembre 30th, 2011 | Author: agaragar | Filed under: au-delà, post-filosofia | 6 Comments »
di Michel Foucault

Perché scriveva Sade? Cosa poteva significare, per Sade, l´esercizio
della scrittura? Dagli elementi biografici che abbiamo su di lui,
sappiamo che ha riempito di inchiostro migliaia di pagine, molte più di
quelle che si sono salvate. Una quantità ragguardevole si è persa, ogni
qualvolta Sade è stato imprigionato. Sade scriveva, infatti, su pezzetti
di carta che gli venivano regolarmente sequestrati. È così che ha
redatto Le 120 giornate, alla Bastiglia, terminandole credo nel 1788-89.
Quando la Bastiglia venne espugnata dai rivoluzionari, quelle pagine gli
furono confiscate. Ecco il lato oscuro della presa della Bastiglia: la
sparizione de Le 120 giornate del Marchese. Fortunatamente queste pagine
vennero ritrovate, ma solo dopo la sua morte. Al tempo, per quella
“perdita”, Sade versò, è lui stesso a ricordarcelo, “lacrime di sangue”.
L´ostinazione che Sade ha posto nella scrittura, le sue lacrime di
sangue unitamente al fatto che ogni volta che pubblicava un libro veniva
sbattuto in galera – ecco, tutto ciò prova che Sade attribuiva alla
scrittura un´importanza ragguardevole. Con il termine “scrittura” non
bisogna intendere il mero fatto di scrivere, ma il fatto di pubblicare.
Poiché – ricordiamocelo – Sade pubblicava i propri testi. E se la
fortuna voleva che, mentre li pubblicava, egli fosse fuori di prigione,
ciò non impediva che fosse arrestato non appena quei medesimi testi
fossero pubblicati. E il tutto proprio a causa della loro pubblicazione.
Da dove viene dunque la serietà della scrittura in Sade? Io credo che a
un primo sguardo sia dovuta a un fatto, a più riprese espresso in
Justine e Juliette. Sade si rivolge ai lettori non in ragione del
piacere che i suoi racconti possono provocare in loro, ma proprio per
ciò che di sgradevole può esservi narrato. Lo dice chiaramente: «Non
avrete di che provare piacere, ascoltando il racconto di storie tanto
raccapriccianti. La virtù punita, il vizio ricompensato, bambini
massacrati, ragazzi e ragazze fatti a pezzi, donne incinte impiccate,
interi ospedali dati alle fiamme. La vostra sensibilità sarà rovesciata,
il vostro cuore non ne potrà più. Ma che cosa volete che vi dica? Non è
alla vostra sensibilità, né al vostro cuore che mi rivolgo. Mi rivolgo
alla vostra ragione – ad essa solamente. Voglio dimostrare una verità
fondamentale, ossia che il vizio viene sempre ricompensato e la virtù
punita». Si pone però un problema. Quando seguiamo un romanzo di Sade,
ci accorgiamo che non c´è assolutamente logica nella ricompensa del
Vizio e nella punizione della Virtù. In effetti, ogni qualvolta Justine,
che è virtuosa, viene punita, la punizione non dipende mai dal fatto che
abbia commesso un errore di ragionamento, che non abbia previsto
qualcosa o sia stata cieca nei confronti di una talaltra cosa. No,
Justine ha calcolato perfettamente tutto, ma le capita sempre una
qualche terribile sventura. Sventura che attiene all´ordine del caso e
come tale la punisce. Justine salva qualcuno? Bene, quando l´ha tratto
in salvo, finisce per massacrarlo. Massacra colui a cui ha appena
salvato la vita. Qui è il caso, sempre il caso, che interviene, mai la
conseguenza logica dei suoi atti. E questo caso determina la punizione.
Quando Sade afferma di indirizzarsi «non al vostro cuore, ma alla vostra
ragione» non è dunque in questione la razionalità del Vizio, né della
Virtù. Sade non si prende seriamente, qui. Ma allora, che cosa vuole
fare quando pretende di indirizzarsi alla nostra ragione, mentre
l´ossatura del racconto si rivolge a tutt´altro orizzonte? Credo che per
capirlo occorra riprendere un passaggio – il solo, in Justine e Juliette
– che si riferisce allo scrivere. Juliette si rivolge a un personaggio,
a un´amica già perversa, ma non totalmente perversa. Non ancora almeno.
Qui si tratta di fare l´ultimo apprendistato, di salire l´ultimo scalino
della perversione. Ecco i consigli di Juliette: «Rimanete quindici
giorni senza occuparvi di lussuria. Distraetevi, divertitevi con altre
cose, ma fino al compimento del quindicesimo giorno non lasciate il
minimo spiraglio alla più piccola idea libertina. Poi coricatevi, da
sola, nella calma, nel silenzio e nell´oscurità più profonda.
Ricordatevi allora di tutto ciò che avete bandito in quei quindici
giorni. Date poi alla vostra immaginazione la libertà di presentare
differenti modi di pervertirvi. Percorreteli nel dettaglio. Passateli in
rassegna. Persuadetevi che tutta la terra vi appartiene e avete il
diritto di cambiare, mutilare, distruggere, rovesciare qualunque essere.
[…] Il delirio si impossesserà di voi. Accendete allora la candela e
trascrivete sui fogli la specie di smarrimento che vi ha infiammato,
senza dimenticare alcuna circostanza che aggravi i dettagli.
Addormentatevi, dopo averlo fatto. L´indomani, rileggete le note e
ricominciate l´operazione». Ecco dunque un testo che chiaramente ci
mostra un modo di usare la scrittura. Un uso chiaro delle scrittura. Si
parte dalla libertà totale assegnata all´immaginazione, si scrive, ci si
addormenta, si rilegge, si procede con un nuovo lavoro
dell´immaginazione, si passa a una nuova elaborazione per mezzo della
scrittura e infine, come dice Sade, alla maniera di una ricetta
culinaria: «Commentate…».
Credo si debba studiare a fondo, in maniera più decisa e precisa, questo
testo. Chiediamoci allora come funziona, in esso, la scrittura. Direi
che in primo luogo la scrittura vi gioca un ruolo intermediario tra
immaginario e reale. Sade, o il personaggio in questione, si dà fin
dall´inizio alla totalità del mondo immaginario possibile e deve quindi
variare questo mondo, superarne i limiti, spostarne le frontiere. Va
oltre, proprio mentre credeva di aver già immaginato tutto, ed è questo
che va trascritto più volte e solo quando sarà arrivato a una data
realtà, allora potrà accedere al famoso: «Commentez ensuite». Come se
fosse facile, commentare quando si è sognato di massacrare migliaia di
bambini, di bruciare centinaia di ospedali, di far esplodere un vulcano…
La scrittura è dunque questo processo, questo momento che ci porta fino
a un reale che, a dirla tutta, spinge il reale fino ai limiti stessi
dell´inesistenza. La scrittura è ciò che permette di spingersi sempre
oltre le frontiere dell´immaginazione. Il principio di realtà o,
piuttosto, la scrittura è ciò che a forza di spinte successive sposta il
momento della conoscenza oltre l´immaginazione. La scrittura è ciò che
forza a far lavorare l´immaginazione, introducendo un ritardo nel
momento in cui il reale finemente si sostituirà al principio di realtà.
La scrittura spinge la realtà fino a divenire irreale quanto
l´immaginazione. La scrittura – ecco la sua prima funzione – abolisce le
frontiere tra realtà e immaginazione. La scrittura esclude la realtà,
ecco quindi che cancella tutti i limiti dell´immaginario.
Ci sono però altre funzioni che orientano la scrittura. La scrittura, in
particolare, cancella il limite temporale, cancella i limiti dello
sfinimento, della fatica, della vecchiaia, della morte. A partire dalla
scrittura, tutto può continuamente, indefinitamente ricominciare. Ma mai
la fatica, mai lo sfinimento, mai la morte si affacceranno in questo
mondo della scrittura, che è precisamente l´elemento che cancella la
differenza tra principio di realtà e principio di piacere. La scrittura
introduce il desiderio nel mondo della verità, togliendo a esso le
briglie e i limiti del lecito e dell´illecito, del permesso e del
proibito, del morale e dell´immorale. La scrittura introduce il
desiderio nello spazio dove tutto il possibile è indefinitamente
possibile e illimitato. La scrittura permette all´immaginazione e al
desiderio di non incontrare più altra cosa che non sia la sua
individualità. Permette al desiderio di essere sempre, in qualche modo,
all´altezza della propria irregolarità. In conseguenza di tutte queste
illimitazioni prodotte dalla scrittura, il desiderio diventa legge a sé
stesso. Diviene sovrano assoluto che detiene la propria verità, la
propria ripetizione, il proprio infinito, la propria istanza di
verifica. Niente potrà più dire al desiderio «sei falso», niente può
rinfacciargli «non sei totalità», niente «è vero ciò che sogni, ma c´è
qualcosa che ti si oppone». Niente può più dire al desiderio «ci sei, ma
la realtà dice un´altra cosa». Grazie alla scrittura, il desiderio è
entrato nel mondo della verità totale, assoluta, illimitata senza
possibile contestazione esterna.
Ecco dunque che, osservata da questa prospettiva, la scrittura sadiana
non ha come caratteristica il mettere in comunicazione, l´imporre, il
suggerire a qualcuno le idee o i sentimenti di un altro. Non si tratta
assolutamente di persuadere qualcuno di una verità esterna. La scrittura
sadiana è una scrittura che non si indirizza a nessuno. Non si indirizza
a nessuno nella misura in cui non si tratta di persuadere a nessuna
verità che avrebbe ipoteticamente nella testa, avrebbe riconosciuto e
dovrebbe quindi imporre al lettore. La scrittura di Sade è una scrittura
assolutamente totalitaria, tanto che nessuno può esserne persuaso in un
senso, e nessuno può comprenderla nell´altro. Ecco dunque che per Sade è
assolutamente necessario che tutti i suoi fantasmi passino per la
scrittura e attraverso la scrittura, in ciò che ha di materiale, poiché,
come ci dice il testo di Juliette, è proprio questa scrittura, quella
materiale, fatta di segni posti su una pagina che possiamo leggere,
correggere, riprendere e via all´infinito – è questa scrittura che mette
il desiderio in uno spazio illimitato, dove ciò che è esteriore, il
tempo, i limiti dell´immaginazione, le concessioni e i divieti, sono
totalmente e definitivamente aboliti.
La scrittura è dunque il desiderio che ha avuto accesso a una verità che
nulla può più contenere. Una verità senza limite. La scrittura è il
desiderio divenuto verità. Verità che ha preso forma di desiderio. Del
desiderio ripetitivo, del desiderio illimitato, del desiderio senza
letto, del desiderio senza esteriorità, dove l´esteriorità è la
soppressione dell´esteriorità in rapporto al desiderio. Questo è quanto
la scrittura porta a compimento, nell´opera di Sade. Ed è la ragione che
lo spinge a scrivere.
Posted: Ottobre 26th, 2011 | Author: agaragar | Filed under: anthropos, epistemes & società, post-filosofia | Commenti disabilitati su Bernard Stiegler
‘‘Proletarizzati di tutto il mondo unitevi… contro la bêtise!’’
Intervista a Bernard Stiegler

Bernard Stiegler, professore al Goldsmiths College di Londra, all’Université de Technologie di Compiègne e visiting professor alla Cambridge University, nonché Direttore dell’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Georges Pompidou di Parigi, è sicuramente uno dei filosofi più attenti alle trasformazioni della società contemporanea, come dimostrano i suoi numerosi libri pubblicati negli ultimi anni. A dispetto di alcuni titoli ”apocalittici” delle sue pubblicazioni – come La misère symbolique o Mécréance et miscrédit – e delle analisi fortemente critiche per le quali è conosciuto anche in Italia (sebbene ancora poco tradotto), Stiegler si distingue sicuramente per la serena volontà di trasformazione sociale, economica, politica e culturale dello stato attuale delle cose, prendendo come bersaglio critico l’ignoranza in quanto fenomeno socialmente prodotto dall’ideologia e dalle tecnologie del consumo. Da questa volontà, condivisa con altri pensatori e studiosi, nasce il progetto di Ars Industrialis, l’associazione di cui Stiegler è presidente e uno dei fondatori. In particolare, l’ambizione di Ars Industrialis, è quella di essere “un’associazione internazionale per l’ecologia industriale dello spirito”, che sappia coniugare critica teorica e proposta programmatica su tutti i piani del sapere, a incominciare dalle scienze umane.
Stiegler ha inoltre pubblicato, qualche anno fa, un libro intitolato La télécratie contre la démocratie, offrendoci così un buon movente per accogliere le sue parole, attraverso un’intervista, in questo numero di Kainos.
[…]