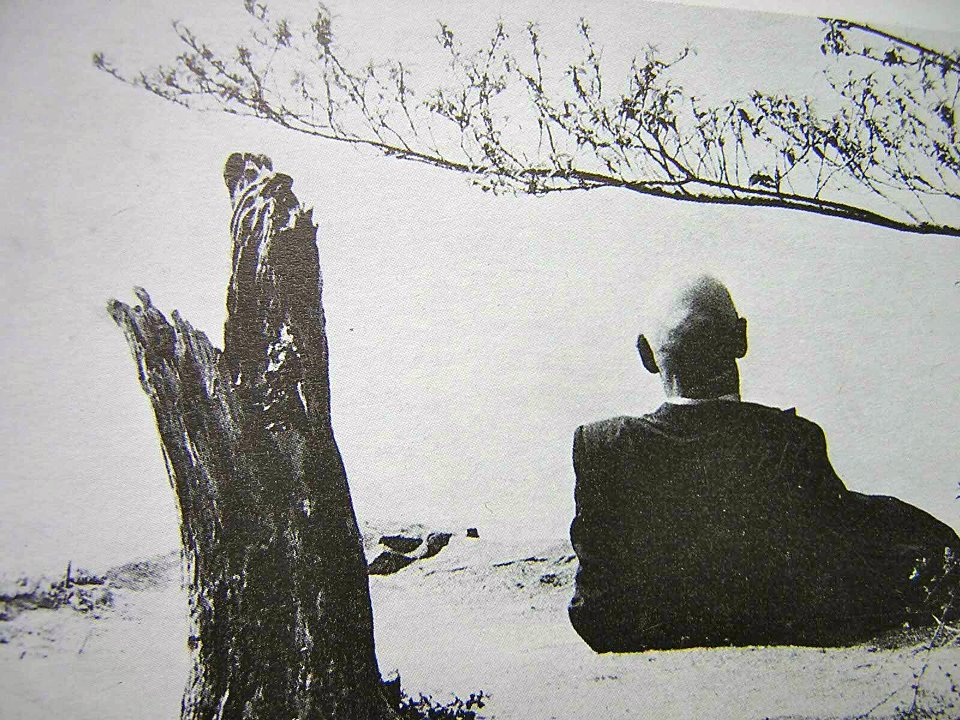Posted: Marzo 7th, 2017 | Author: agaragar | Filed under: au-delà, lacanism, postcapitalismo cognitivo | 19 Comments »
Un documentario di Maurizio Gibertini sull’opera di Paolo Gallerani
di Federico Chicchi
Alberto Grifi ha girato, nell’oramai lontano 1977, uno dei documentari più sconvolgenti e politicamente incisivi che abbia mai visto. Il documentario intitolato Il preteso corpo racconta gli esperimenti di un medicinale fabbricato dalla casa farmaceutica “Roche” su persone considerate psicologicamente insane. Trovato per caso in un mercatino a Milano, il readymade di Grifi testimonia di come la sperimentazione farmacologica provocava sulle cavie umane orribili convulsioni e sofferenze indicibili. Questa sofferenza rappresenta nella metafora l’esito dell’azione del capitalismo sulla vita. Trovo che anche il lavoro di Paolo Gallerani recentemente esposto alla Casa della Memoria di Milano (oltre sessanta opere tra sculture, disegni, carte e fotografi) abbia per certi versi a che fare con questa pretesa. Per questo se ne rimane immediatamente coinvolti, c’è qualcosa nella sua arte che dice del disagio del corpo in frantumi, fatto a pezzi nella stanza delle pulegge del capitalismo.

Il lavoro artistico di Paolo Gallerani in realtà non può essere ridotto a questo motivo, esso traccia e dipana spudoratamente diverse ragioni contemporaneamente, intrecciando in maniera stretta, fino a renderla impalpabile, la differenza tra vita e artificio. Non si lascia raccontare facilmente la poesia, profondamente materialistica, di questo geniale ed ecclettico artista, o meglio non si lascia raccogliere in un medium espositivo tradizionale. Tracima da ogni parte, come se lo spazio che la circonda fosse sì quantitativamente capace di contenerla ma al contempo incapace di frenarla qualitativamente. Credo che questo sia dovuto al fatto che l’opera di Gallerani tenta di cogliere la forza, la pulsione, il reale, l’eccedenza che recalcitra.
Questo è poi particolarmente evidente in alcune sue bellissime opere recenti, come ad esempio la Nike (2011), un missile/antimissile che l’arte libera dalla sua funzione guerrafondaia e disumana per mostrarne invece una tremolante ma precisa vocazione estetica nascosta, e prima che l’artista ci mettesse mano, del tutto latente.
Ecco perché il documentario di Maurizio Gibertini (realizzato per OfficinaMultimediale) che ci presenta il modo in cui questa mostra è stata montata e realizzata ha un valore inestimabile, perché punta lo sguardo al lavoro di Gallerani senza tentare di rinchiuderlo, anzi facendolo esplodere attraverso tecniche espressive mirate come l’improvvisa inserzione di immagini documentaristiche, i tagli e i piani sequenza.
Due sono i movimenti che le opere di Gallerani producono a mio avviso su chi le osserva per la prima volta. Il primo movimento appartiene alla dinamica del in-compiuto, un incompiuto che non ammicca a ciò che manca ma al contrario spinge al divenire necessario (insistente e materiale potremmo dire) dell’opera, che attraversata dalla vita, continua a compiersi all’infinito. È il caso della cassa con gli stralci delle vigne, dove quest’ultimi pur mutilati, privati della luce e strappati dalla terra continuano a produrre vita nella sua forma microrganica; o degli alberi lavorati che il documentario realizzato da OfficinaMutimediale mette giustamente in risalto nei suoi dettagli. L’altro movimento, strettamente legato al primo, è quello dello strato o meglio dell’accumulazione dei segni che si producono in seno all’opera. L’opera dell’artista centese non è rappresentabile con il piano liscio, levigato, pareggiato ma è al contrario sempre un rizoma di scarti che si accumulano, scarti che mostrano il conflitto, l’incompletezza, l’entropia, la ricchezza del vivente, il suo perenne godimento in atto. Il trauma quindi, il trauma dell’albero che si fa cannone, e il trauma del cannone che cerca di farsi albero. È la lotta aperta che pone l’uomo al centro di questa torsione, contemporaneamente come attore e come oggetto passivo di questo movimento. C’è un dolore che attraversa l’opera di Gallerani, un dolore che viene lavorato affinché assuma la torsione generativa della poetica: «l’arte deve avere il coraggio di confrontarsi con la catastrofe».
È l’arte o l’autore (l’artista), il protagonista dell’opera di Paolo Gallerani? Non saprei dire. Nel documentario emerge sia la figura umana dell’artista che la forza dell’arte che sfugge al controllo di chi la crea, che rappresenta un piano non governabile a cui occorre, per certi versi, accondiscendere.
In che relazione stanno i cannoni e gli alberi di Gallerani? Sarebbe troppo semplice dire che stanno in opposizione. Non c’è alcuna nostalgia naturalistica, nessun purezza da recuperare, negli alberi artigianati e lavorati dall’autore. Sono invece presi i due materiali, il ferro opaco e il legno chiarificato del tronco, in una congiunzione disgiuntiva dove in gioco c’è proprio il tema della in-appartenenza dell’uomo al mondo. O meglio il tema della ricerca per nulla scontata che l’uomo deve ad ogni passo fare per tentare di abitare il reale impossibile della vita.
In tal senso La stanza delle pulegge realizzata nel 1986 da Gallerani e Le macchine armate, su cui il documento visivo di Maurizio Gibertini ci consegna la storia e uno spaccato di rara intensità, devono a mio avviso essere osservate come se fossero l’una il rovescio dell’altra, l’una la trama del filato artistico dell’altra.
Gallerani, in questo come Kounellis, rompe con l’idea che l’arte del sensibile sia destinata ad essere superata dalla superiorità del logos. A questa «barzelletta» hegeliana l’artista risponde con la tracotanza della materialità dell’opera che si prende gioco del concetto mostrandone appunto l’inesattezza e la inevitabile bestialità. Nulla nel reale è solo razionale. Potremmo dire che Gallerani, pur non evocandolo mai direttamente da un punto di vista anatomico, attraverso le sue opere, faccia corpo, consistenza. Ma di che cosa? Corpo dell’evento, dell’imprevisto, del perturbante dello scontato. Come il corpo che abitiamo è sempre lo stesso medesimo corpo e mai è del tutto lo stesso. Gli accumuli che accompagnano disordinatamente gli oggetti inanimati di Gallerani, privandoli della loro funzionalità, uccidono la simbologia dell’oggetto, per donarli ad una nuova immagine del sensibile che non si accontenta della sua utilizzabilità precedente. Ecco, potremmo dire che l’incompiuto delle opere di Gallerani esprime l’impossibilità delle forme simboliche ad ospitare le forze della vita. Quest’ultima degenera sempre e si corrompe mostruosamente se non troviamo la chiave per accettare lo slancio che offre. È qui che risiede la vena nostalgica e preoccupata che l’opera di Gallerani stimola in chi la osserva. Non è una nostalgia che punta, come in Pasolini, perversamente a una purezza originaria corrotta e da ritrovare. Niente di tutto ciò.
Una chiave di questa sfida, che potremmo anche forse chiamare progetto per una politica per la vita (e non sulla vita), è la scrittura poetica. La Nike, l’opera di cui dicevamo, poc’anzi ce ne consegna la (una possibile) chiave di lettura. Il missile antimissile montato su di un carro che lo mette in condizione di avanzare, insieme ad alcuni innesti imprevedibili che ne perturbano la liscia fallicità. Alcuni di questi innesti sono organici (rami che spuntano come da un tronco dalla macchina/albero da guerra), altri sono testuali. Tra questi, in primo luogo, James Joyce che l’artista ha dichiarato essere fonte importante di ispirazione di quest’opera.
Lacan, come è noto, ha dedicato il suo Seminario XXIII alla figura di Joyce. Cosa vi vedeva di così significativo il grande psicoanalista francese nello scrittore dell’Ulisse? Vi vedeva la possibilità di nominarsi attraverso l’opera, di ricomporre il corpo in frantumi attraverso la scrittura. Attraverso l’opera Joyce ricostituisce il suo nome. In tal senso l’opera di Gallerani rappresenta il tentativo “joyciano” di produrre sul piano collettivo, in questo caso, una glossografia, che significa tentare di scrivere l’illeggibile e l’intrasmissibile per generare l’imprevisto e aprire un varco verso il nuovo passando attraverso l’estetica di un sogno comune.
Posted: Dicembre 29th, 2016 | Author: agaragar | Filed under: au-delà, Deleuze, post-filosofia | Commenti disabilitati su Deleuze, il movimento reale del molteplice
di Giso Amendola
Tempi presenti. Il saggio «Gilles Deleuze» (DeriveApprodi) di Michael Hardt libera il campo dalla lettura neoliberista del filosofo francese. E svela la politicità dell’opera, considerandola come un nodo nella trama critica dello status quo

All’inizio degli anni Novanta, nel 1993, due anni prima della morte di Gilles Deleuze, Michael Hardt pubblica uno dei primi lavori monografici in lingua inglese dedicati al filosofo di Logica del senso e Differenza e ripetizione: oggi Gilles Deleuze. Un apprendistato in filosofia torna disponibile grazie a DeriveApprodi e alla “neonata” collana Operaviva (l’edizione italiana è a cura di Girolamo De Michele, la traduzione è di Cecilia Savi).
Quando esce originariamente il libro di Hardt, la recezione di Deleuze nei paesi anglosassoni sta avvenendo a seguito di quell’ondata di interesse per il pensiero radicale continentale che ci avrebbe fatto parlare poi di una French Theory. Il libro di Michael Hardt ha davanti originariamente questo panorama: il poststrutturalismo è stato sì accolto nel panorama americano, ma è stato letto soprattutto come una sorta di più o meno ironica e disincantata critica del fondamento, un abbandono lineare e senza scosse della tradizione filosofica, senza che questo congedo riesca a sviluppare una reale potenza costruttiva e critica.
L’obiettivo dichiarato di Hardt è quello di ribaltare questa visione del poststrutturalismo: si tratta di rivendicare al poststrutturalismo la capacità di attraversare la modernità cercandone le “filiazioni alternative”, e di affrontare la questione del fondamento evitando di rimanere impigliati nella meditazione perpetua sulla sua eclissi.
Le tappe di un percorso
Oggi le carte in tavola sono cambiate: più che mirare a spegnere la sua forza critica edulacorandola, l’attacco al poststrutturalismo, e a Foucault e Deleuze in particolare, tende esplicitamente ad accusarlo per una sorta di complicità, più o meno consapevole, con lo stesso neoliberalismo. Il desiderio in Deleuze? Cedimento alle passioni “appropriative” del neoliberalismo. L’attenzione alle soggettività, alla pluralità, al divenire e alla trasformazione? Apologia, più o meno mascherata, dell’individualismo, del soggetto-impresa. Davanti a questa nuova, fastidiosa chiacchiera, la ripubblicazione del libro di Hardt è una boccata d’aria salubre, e, insieme, una sfida quasi provocatoria a tutti i discorsi sull’ambiguità politica del poststrutturalismo.
La lettura che Hardt offre di Deleuze, e più precisamente dei suoi primi grandi incontri filosofici con Bergson, Nietzsche e Spinoza, si separa infatti da qualsiasi concessione alle retoriche di un facile “postfondazionismo”: è anzi una rivendicazione fortissima del nesso tra ontologia, etica e politica nel discorso deleuziano. La forza di queste pagine, oggi forse ancor meglio apprezzabile, è mostrare come il poststrutturalismo, per quanto ci si affanni a mostrarlo come un astruso gioco culturale, se non “culturalista”, sia in realtà ben impiantato nel campo della produzione: produzione dell’essere, della soggettività, e infine dell’organizzazione.
Prima stazione del percorso: la questione ontologica. Questione spinosa, a cominciare dallo stesso uso del termine “ontologia”. Perché – ed Hardt ne è perfettamente consapevole – la tradizione filosofica ha operato un vero e proprio sequestro del discorso ontologico. La ripresa dell’ontologia nel Novecento richiama immediatamente la concezione della differenza in Heidegger, tutta nel segno del sottrarsi dell’essere, del ritirarsi del fondamento: non a caso, è ontologia frequentata da tutte le meditazioni sull’eclissi dell’essere, di indole sia tragica che ironica, che popolano il postmoderno.
Di ontologia in Deleuze, invece, si può parlare a buon diritto proprio in quanto la si installa all’interno di tutt’altra tradizione: quella affermativa e positiva che legge la differenza come produzione interna dell’essere, e immanente all’essere stesso. La differenza non “cade” dall’essere, non lo nasconde, non lo cancella, come avviene nell’emanazionismo di marca neoplatonica: la differenza non è destinata ad errare nel mondo delle ombre. Hegel imputava una concezione di questo tipo, dove l’essere fa impallidire ogni differenza, proprio a Spinoza: Deleuze invece ricolloca l’ontologia spinoziana al posto che le pertiene, all’interno di una concezione, che il filosofo francese chiarisce già nei suoi primi scritti su Bergson, secondo la quale la differenza, anzi le differenze, sono movimento dell’essere, non distanza e caduta dall’essere e suo infinito consumarsi.
Ma ancor più che contro la “differenza ontologica” di Heidegger, l’ontologia deleuziana ha come suo nemico principale la dialettica hegeliana. Per Hegel, la differenza non può che essere concepita come determinazione: a sua volta, la determinazione è un movimento di negazione. Ci si determina negando attivamente l’indifferenziato, l’indeterminato, in ultima analisi negando quel nulla che coincide con la purezza astratta dell’essere.
8clt1fotinapiccola
Oltre Hegel
È, per l’appunto, l’attacco fondamentale di Hegel a Spinoza, poi ripetuto da tutti coloro che vedranno nell’idea dell’essere produttivo sempre una minaccia dell’informe, del caotico, del mancante di differenziazione. La replica di Deleuze è molto decisa: la determinazione come atto di negazione non fa altro che introdurre una dimensione radicalmente esterna al movimento dell’essere. La negazione fa dipendere la determinazione da una causa esterna: l’essere che si determina negandosi è un essere eternamente dipendente, sempre bisognoso di qualcos’altro.
Hardt richiama giustamente l’attenzione sull’importanza che ha il concetto di causa efficiente nell’ontologia deleuziana: la causa necessaria, non contingente, non è mai la causa materiale, cui guardano tutti i materialisti ingenui, che interviene in modo del tutto contingente, e neppure la causa finale, amata dai platonici, che pone l’ordine come fine trascendente: l’unico concetto di causa che può muovere un materialismo fondato sulla potenza produttiva dell’essere, è la causa efficiente, la causa sui degli scolastici.
L’effetto non cade mai al di fuori della causa, e, allo stesso modo, la differenza è sempre produzione interna del movimento dell’essere: l’essere non manca di nulla. Non opposita, sed diversa: non la determinazione per opposizione e negazione, ma l’essere come matrice di produzione di differenze.
Superamento del negativo
Questa opposizione netta all’idea di determinazione per negazione da un lato segna tutta l’ontologia produttiva deleuziana, dall’altro apre alla sua portata etica affermativa. Ci sono nel testo di Hardt alcune pagine bellissime, sulla dialettica servo-padrone, che chiariscono come la scelta deleuziana per il movimento positivo della differenza, contro la determinazione attraverso il negativo, ci porti nel cuore di scelte etico-politiche fondamentali.
Cosa significa, concretamente, immaginare la differenza come negazione? Significa per esempio, che il servo hegeliano sceglie di determinarsi, di fronte all’assoluto indeterminato che è la morte, rivolgendo la propria forza contro se stesso, realizzando la propria autocoscienza attraverso l’educazione al lavoro. Nei termini di Nietzsche, si tratta di una triste e infelice etica del risentimento contro la propria stessa potenza. In termini hegeliani, è attraverso il negativo, tenendo a freno il desiderio, che lo schiavo conquista la sua essenza.
Hardt ricorda qui l’Alfonso voce narrante e protagonista del Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, il giovane migrante meridionale nelle fabbriche del Nord Italia degli anni Sessanta e Settanta: “mai mi è venuto in mente di festeggiare il lavoro”, dice Alfonso, quelli che individuavano pane e lavoro come propria essenza erano irrecuperabili. Primo movimento: distruggere l’idea che ci si determini nel trattenimento, in un dirigersi della propria forza contro se stessi. Appunto, distruggere l’idea che “ogni determinazione è negazione”.
Contemporaneamente, si apre il secondo movimento: la distruzione del negativo diventa scoperta felice che quella esigenza di lotta, di liberazione della propria forza, è esigenza condivisa negli incontri: “la gioia di essere finalmente forti. Di scoprire che ste esigenze che avevano sta lotta che facevano erano le esigenze di tutti era la lotta di tutti”, sempre per dirla con le parole di Alfonso.
L’incontro con Spinoza
Non si potrebbe indicare meglio che con questa gioia di operai irriducibili al lavoro che scoprono la pars construens della loro lotta, il passaggio dall’ontologia all’etica: dall’essere come produzione, all’essere come producibile, per dirla con Hardt. L’affermazione ontologica dell’essere come produzione immanente, causa sui, distrugge l’alterità del fondamento, la sua lontananza, e contemporaneamente, afferma l’essere stesso come il risultato, sempre aperto, di un processo di produzione da parte delle differenze.
Hardt, indagando soprattutto l’incontro di Deleuze con Spinoza, aiuta qui a fare piazza pulita di un altro ritornello, spesso recitato dai custodi del “negativo”: quello per cui questa visione dell’essere come produzione ci consegnerebbe a una sorta di beatitudine statica, a un ottimismo metafisico paradossalmente impotente. Il punto è che l’ontologia della produttività dell’essere ci apre sì a un essere “mobile e malleabile”, dinamico e produttivo: ma, allo stesso tempo, ricorda Hardt “alla potenza di esistere e di agire corrisponde la potenza di essere affetto”.
Deleuze trova specialmente in Spinoza questa congiunzione tra produzione e affezione: affezioni attive, che corrispondono all’essere causa di noi stessi, adeguati alla nostra potenza attiva d’essere e produrre, ma anche affezioni passive, da cause esterne, dove la potenza non coincide con la propria causa. E questo incrocio materialistico di produzione e affezione apre tutto il gioco degli incontri, felici o infelici, delle variazioni della potenza, del suo accrescersi in combinazioni che corrispondono felicemente alla struttura dei corpi, come del suo andare a male negli incontri inappropriati. L’essere non solo non è il fondamento che, immoto, ci sostiene, non solo è il processo sempre aperto che ci produce ma è, al tempo stesso, anche il prodotto della nostra capacità, sempre reversibile, di trasformarci attraverso affetti e passioni.
La politicità riscoperta
Da questa etica della produzione della soggettività, ontologicamente impiantata, si genera una politica degli assemblaggi e della sperimentazione di organizzazione, a partire dal piano sempre aperto della trasformazione sociale. Alla determinazione attraverso il negativo corrisponde l’idea di un Ordine che si impone sempre come causa esterna su un molteplice, letto inevitabilmente come campo del mancante e del carente, bisognoso dei suoi pastori: l’ontologia produttiva apre invece lo spazio di una politica che certo “benedice” il molteplice e la pluralità, ma che non per questo ignora il nemico, le sanguisughe che separano continuamente la potenza dalla sua causa, che provano a recintarla attraverso le “strutture verticali dell’ordine”.
Un campo aperto: e certo aperto resta completamente il tema, intensamente politico, dell’organizzazione e della costituzione, in altri termini il problema di come evitare che questa incessante produttività della società si affermi solo in un campo d’orizzontalità liscio, senza riuscire a darsi consistenza e durata. Molti materiali, nel lavoro remoto e recente sulla politica deleuziana, possono approfondire concetti fondamentali come, per esempio, quello di istituzione: pensiamo per esempio, alle ricerche che sull’istituzione in Deleuze ha condotto negli anni Ubaldo Fadini, nel segno di uno sviluppo originale del tema della “positività” in Deleuze, o a tutto il dibattito recente sulla giurisprudenza in Deleuze come modello alternativo alle concezioni legalistiche del diritto (ne è un esempio un libro di De Sutter su Deleuze e il diritto di qualche anno fa).
Intanto, questo solido materialismo radicato nella produzione/produttività dell’essere può lottare contro il neoliberalismo strappandogli il vero segreto della sua potenza: l’infamia con cui traduce nel linguaggio della proprietà e della valorizzazione capitalista la forza dell’autonomia della cooperazione sociale, del pluralismo e dell’autorganizzazione. Altro che alleati del neoliberalismo: questi poststrutturalisti che scansano felicemente il negativo e benedicono il molteplice sono quelli che insegnano come affrontare il nemico senza attestarsi su posizioni reattive o nostalgiche, come non lasciare ai neoliberali la forza di un sociale capace di affermazione e di trasformazione.